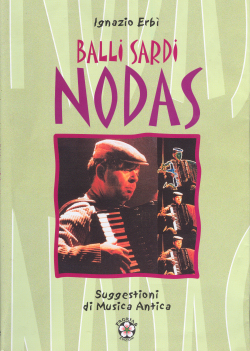
Passione e razionalità nel ballo sardo
in Nodas di Ignazio Erbì
1999, Edizioni Frorìas
Una frase sentita più volte da piccolo mi faceva sorridere dell’assurda irrazionalità de sos mannos: “Cando intendo sonu ‘e ballu si mi fuin sos pedes e no mi potto mantenner”. Abituato a vivere nel fermo e rigido controllo del linguaggio del corpo sentivo quella frase in forte contraddizione con la filosofia della mia pesanzia. Eppure, fin dai primi mesi di vita, ero stato abituato anch’io al movimento ritmato delle poesie cantate dai nonni e da mia madre a duru-duru.
La flessuosità sulle punte dei piedi, gli scatti di gambe e di reni nella rigidità del corpo che muove verso l’alto erano ormai parte del corredo esperienziale su cui si fonda il patrimonio dei saperi comuni alla mia gente.
Ogni accento contenuto nelle parole delle poesie in verso ottonario o endecasillabo o nelle onomatopeiche imitazioni degli strumenti musicali, che costituivano la dimensione del significante, produceva i movimenti articolatori del ballo quasi come brividi sfuggenti al controllo razionale.
Intorno ai cinque anni un regalo continuava il senso di quella pedagogia: l’armonica a bocca. Espirando e inspirando l’aria per far vibrare le linguette metalliche contenute nei buchi quadrati di quello strumento si cercava di articolare il linguaggio musicale del ballo seguendo il “mascherone” di alcuni numeri che gli adulti ci consegnavano come paradigma della creazione musicale: 30, 40, 100, 91.
Trìnta, barànta, chèntu, novantùnu costituivano la formula magica della stesura iniziale del Ballu Torrau. Acquisita quella formula de Istèrrida era possibile procedere alla ripetizione della seconda frase paradigmatica costitutiva della Torràda e il cerchio della comunicazione fra significato e insignificante si chiudeva per disporci, con il sorriso, alla produzione autonoma delle frasi musicali per il ballo.
Marìdu chèret e no nde li dàna era la frase che ci incuriosiva e nel divertirci stimolava alla ripetizione del messaggio. A chi si riferiva il contenuto di quella Torràda?
Ingannati dalla curiosità si continuava a versare aria e saliva nello strumento-giocattolo fino ad imparare la costruzione delle frasi che compongono la lingua del ballo.
Stendere per intero la prima frase non basta: la sola Istèrrida rimane sospesa, come una frase interlocutoria.
Occorre ripeterla più volte per stabilire il ritmo e raggiunto questo si deve introdurre la seconda frase, sa Torràda. Eseguire queste due frasi, ripeterle nella giusta scansione periodica significa entrare nella dimensione del gioco di produzione ritmico-musicale per affermare abilità creativa e competenza esecutiva. Ma il gioco non vive di sola ripetizione.
La sua affermazione si realizza nella capacità interpretativa costruita nella consapevolezza della trasgressione, e del superamento, delle regole grammaticali comuni a ogni forma comunicativa del quotidiano, dunque anche del ballo. Si spezzano le frasi in frammenti riconoscibili, si prolifera nel numero che si ritiene opportuno fino al limite della riconoscibilità testuale, si espande con riproposizioni lineari o rovesciate e invertite: si fiorisce e orna di espressioni stilistiche per assegnarle un tratto distintivo, personale. Un marchio di riconoscimento attestante la paternità.
La conferma della abilità nella creazione musicale si raggiunge nella verifica dell’esecuzione coreutica.
A sas nodas prodotte dallo strumento trovano corrispondenza i passi dei ballerini, le battute dei loro tacchi al suolo, le accelerazioni del ritmo e le evoluzioni dei corpi dentro il cerchio introverso. Si stabilisce una stretta identità fra suono e movimento.
Alla geometria dei passi giocata fra stabilità del corpo e fioritura delle figure aggiuntive disegnate dalla punta del piede destro portato in avanti e indietro, su entrambi i lati del sinistro fisso al suolo, corrisponde l’architettura sonora articolata su frasi essenziali sviluppate in ripetuti frammenti di queste per aprire nuovi percorsi.
Gli accordi dello strumento si fondono ai ritmati rumori dei passi de su ballu in un unico, ricco e complesso intreccio armonico. Scattano sincronicamente decodifica e produzione di suono e passo nel sistema percettivo dei sardi per realizzare la chiusura del cerchio dei corpi del ballo fra esercizio fisico personale e momento di aggregazione sociale, per conoscersi e riconoscersi nel movimento e nel segno circolare.
La testimonianza più esplicita della circolarità, quale segno distintivo della struttura culturale antropologica, si evince in maniera inequivocabile nello studio dei balli sardi.
La competenza elaborativa delle espressioni artistico-culturali del popolo sardo risiede nella capacità di mettere a punto delle forme compositive essenziali, rivisitabili dall’interno del profondo solco della tradizione in modo da attribuire ogni volta nuovo vigore espressivo, per riconoscerle e sentirle sempre attuali nonostante il lento trascorrere dei secoli.
La vera invenzione è nella particolare conformazione basilare della loro grammatica: fittamente intrecciata, fortemente tessuta, solidamente verificata, largamente estesa a tutti gli innumerevoli codici espressivi.
All’origine di tutto sta la ricerca-assunzione di due strutture linguistiche ineludibili per gli isolani: s’Istèrrida e sa Torràda. Sono l’alfa e l’omega della comunicazione sarda. Appartengono alla letteratura de sos contos de foghìle e alla poesia, al canto e al ballo, al linguaggio quotidiano e alla produzione musicale: l’una non vive separata dall’altra. Si produrrebbe il divario, si accenderebbe il debito, si scaverebbe l’incolmabile fossato dell’incomprensione, si scatenerebbe la lacerazione dei rapporti.
Queste due strutture costituiscono l’alveo entro il quale maturano le creatività espressive determinate nella costruzione della abilità esecutiva, nello sviluppo del gusto estetico personale, nell’affinamento delle tecniche e degli stili, nell’espansione della forza rielaborativa misurata fra l’aderenza a su connottu e l’invito alla rilettura, nella consapevolezza del gradimento-accettazione fra il pubblico-consumatore.
Si inizia con l’acquisizione della passione per l’espressione che si matura nella abilità della pratica dell’ascolto, nella pedagogia dell’osservazione, nell’attenzione alla comprensione dei codici componenti i più svariati linguaggi. Di sicuro i primi modelli si trovavano nella natura della nostra isola. L’imitazione di quei linguaggi e di quelle forme ha costituito la prima modalità di approccio per l’uomo.
Acquisita la padronanza delle strutture portanti, che compongono il linguaggio artistico-espressivo, si passa alla fase di produzione creativa in cui gli attori procedono all’elaborazione di stili personali attraverso i quali lasciare una impronta indelebile nella memoria dei propri simili.
E’ una grande impresa di natura estetica che riesce solo nella misura in cui il neo-produttore è stato capace di osservare, comprendere, imparare e rielaborare le forme espressive del popolo riuscendo a rileggerle senza tradirle. In quel momento l’attore del “nuovo” linguaggio diventa il modello per tutti coloro che intendano, in quella collettività, perpetuare quei percorsi identitari.
Ignazio Erbì è da considerarsi un modello per chiunque, oggi, voglia accostarsi con amore alla conoscenza delle forme e degli stili esecutivi del ballo sardo. Sua è la sapiente competenza di eseguire facendo scivolare le abili dita della mano destra sui tasti della fisarmonica come sulle canne della mancosa e della mancosedda per creare dialogo con le dita della mano sinistra che accarezzano i bassi come nella lunga canna del tumbu. Il suo nome è strettamente legato alla storia del ballo nella memoria del suo paese natale come di tutta l’area campidanese e dell’intera isola. Imitare si propone come modello pedagogico per creare nuova espressione anche nel ballo.
I movimenti del corpo degli animali, i loro balletti di corteggiamento, le loro sfrenate corse ora in avanti e subito dopo indietro, gli stacchi improvvisi da terra verso l’alto e il loro ricadere con grazia sul suolo rivivono nell’espressione coreutica di balli dei paesi dell’interno dell’isola. Si distinguono i balzi sulle punte dei piedi che manifestano agilità di giovani animali felici: è l’inno alla vita intonato dallo scontro delle corna – istumburinadas – di mufloni per annunciare l’arrivo della pioggia.
La sonorità della natura è il sema del vocabolario delle tradizioni musicali sarde: l’onomatopeico istumburinare delle corna ritorna nel tumbare una ‘oche del canto a Tenore, nel tumbare su ballu, nel Tumbu (la canna più lunga che emette il suono continuo di bordòne) delle Launeddas, in su Tumba-rinu, strumento a percussione diffuso nell’intera isola.
LE REGOLE DI PARTECIPAZIONE
E’ impossibile stabilire il momento in cui il rito officiato da una persona si è fatto tradizione popolare compartecipata da una collettività intera. Tale difficoltà nasce dalla totale assenza – o perdita? – del termine rito nella lingua sarda in ciascuna delle sue varietà. Resiste invece il verbo offissare per intendere fare, occuparsi di qualcosa, rivolgere l’attenzione verso qualcosa.
Un aspetto assai curioso nell’uso di questo verbo è che esso viene rivolto a singolo individuo, o a pluralità, solo in frasi interrogative: ite seis offissande? Non esiste possibilità di reimpiego del verbo per costruire la risposta articolata in icastici gerundi: cantande, contande contos, fachende semus.
Così è difficile stabilire in quale data la tradizione popolare sia diventata Folclore, attribuendo a questo vocabolo il significato di “proposizione davanti ad un pubblico di spettatori” di una forma di espressione decontestualizzata.
Il 931 segna, in mancanza di altre attestazioni, la data in cui alcuni sardi anziché cantare per la propria gioia “accolsero l’imperatore bizantino con un canto”. Il salto dalla tradizione popolare al folclore è immenso: la prima presuppone un agire comune dei membri della collettività per costruire insieme una espressione caratterizzante del gruppo, il secondo implica una scelta di attori per rappresentare l’esecuzione di moduli espressivi “in uso” presso una collettività.
La dicotomia Folclore/Tradizione si sviluppa dunque nel carattere di sincronicità o di diacronicità delle forme rappresentate dai detentori privilegiati.
Non è in discussione che essi siano espressione di “ceto popolare”, riconosciuti dalla collettività quali ottimi interpreti dei codici più aderenti alla forma della Tradizione fermata ad un particolare momento della storia del paese.
Il trasferimento del ballo o del canto dal suolo della piazza alla sopraelevazione del palco, il numero dei partecipanti, il corollario degli spettatori trasformano il flash-back della espressione comunicativa di un popolo in performance folcloristica di pochi attori. L’esibizione si carica di segni negativi impropri al fare ballo e al fare canto della Tradizione perché vincolata al giudizio degli spettatori estimatori come al severo controllo del capo-gruppo. Tutto viene calcolato nei dettagli, tutto è previsto, programmato e per ciò deve funzionare. Se qualcosa va storto è facile individuarne la responsabilità tutta umana.
Nella Tradizione per contro niente è prevedibile: una cantata riesce alla perfezione e un’altra stona irrimediabilmente. Se il rito non si articola con regolarità secondo i canoni dell’intonazione e dell’accordo armonico fra le voci la colpa viene attribuita alla dea Mutta. Non ha forme questa divinità. E’ il capro espiatorio di ogni malfunzionamento perché si è bevuto troppo, perché pensieri esterni turbano uno dei cantori, perché non cantano da mesi e le loro corde vocali non sono più abituate allo sforzo, perché intorno c’è gran confusione, perché manca l’estro.
Il rito deve essere officiato. Solo se una divinità è contraria – sa Mutta mala – si rinuncia, non senza aver provato. Altrimenti si canta con la benevolenza de sa Mutta bona. L’imperativo è fare cerchio di canto per perpetuare un mito. Non c’è rappresentazione in tutto questo, siamo lontani da qualunque forma di folclorizzazione dell’espressione comunicativa popolare.
Certo si registrano sollecitazioni esterne che hanno modificato il paradigma dei moduli del canto, del ballo, dell’esecuzione strumentale. E’ sufficiente un riscontro fra registrazioni degli anni cinquanta e quelle odierne per cogliere un processo di affinamento nella combinazione delle armonie per costruire con più grazia il tessuto sonoro delle voci dei cori a Tenore e dei suoni delle Launeddas.
La ricerca estetica sviluppatasi nella capacità di confronto fra le produzioni di diversi paesi ha prodotto importanti modificazioni anche nell’espressione del linguaggio del corpo e le forme coreutiche ne risultano fortemente investite.
Il Folclore finisce per testimoniare forme ormai superate nella produzione popolare, ancora viva e produttiva di riletture e rielaborazioni verificabili nel canto a chitarra e nella poesia improvvisata logudoresi. La produzione espressiva di singoli sembrerebbe perciò aderire meglio ai moduli de su connottu?
Il suonatore di fisarmonica, di organetto diatonico, di armonica a bocca o di scacciapensieri, gode di una maggiore libertà di interpretazione poiché esprime una “ricerca di stile” personale. Tale ricerca sconfina oggi troppo spesso nel solo versante delle sonorità, ricche, accurate, fiorite, ornate, tanto da non riconoscervi più la grammatica del ballo perché… molti dei suonatori non sanno ballare!
Ma mentre i suonatori cercano una naturale via all’affermazione personale come strumentisti del gruppo folk oppure nel mercato discografico isolano con incisioni che intendono testimoniare una presenza musicale nel patrimonio emico paesano, altre forme come il canto a Tenore e su Cuncordu continuano a strutturarsi come momenti di godimento personale da condividere con gli altri componenti della formazione polivocale.
L’EXTRA-TERRITORIALITÀ DEL CERCHIO
La dimensione temporale della cantata come del ballo è cambiata rispetto a quella della Tradizione. Non si aspetta più la ricorrenza del calendario liturgico per fare Bassu, Contra, Boche o Mesu’oche. Dunque viene a modificarsi anche la dimensione sacra del luogo: non più, e non solo, la festa del santo, ma ogni luogo e ogni momento si offra al pretesto de istare in cumpanzia.
Come nello strumento telematico si abbattono le barriere spaziali e temporali e non importa conoscere le persone con cui si produce lo scambio comunicativo, così ci si stringe in cer-chio nei bar o per le strade di tanti paesi dell’interno dell’isola dove non è raro incontrare crocchi di persone che cantano o ballano.
A volte i cantori sono affiatati da legami di conoscenza o amicizia remota, alcuni si frequentano quotidianamente condividendo il medesimo posto di lavoro o perché abitano nello stesso bichinadu, ma spesso si incontrano e cantano insieme persone che non si trattan (frequentano). La mancanza di un collaudato legame di conoscenza non li esime da uno stretto contatto corporeo fatto di incroci di gambe e di piedi, di braccia e di mani, di sguardi di complicità, di reciproci aggrottamenti di sopracciglia e di accennati ma eloquenti sorrisi di approvazione mentre il bicchiere circola dalle mani dell’uno per portarsi alle labbra dell’altro fino a completare il giro.
Nel canto scompaiono gli uomini per lasciare spazio ai pezzos – ruoli – ricoperti da pastori o studenti, da impiegati o disoccupati, da laureati o da semi-analfabeti, da sessantenni o ventenni, da amici e sconosciuti. Non di rado capita che nel cerchio dei cantori o dei ballerini si ritrovino persone fra le quali i rapporti umani sono da tempo interrotti, lacerati da astio, ossidati dal rancore.
La necessità di “fare cerchio” per il canto o per il ballo prevale sui rapporti dei singoli individui. La celebrazione del rito e la continuazione del mito hanno priorità sulla socializzazione fra le persone, o forse la comunicazione fra sardi ha bisogno di questo rito per continuare ad affermare il mito dell’identità culturale.
Di certo fare cerchio per cantare e ballare rimane un’esigenza sentita in misura assai forte perché attraverso la partecipazione si attesta la volontà di appartenere al vissuto dei propri simili. Dunque non esiste narcisismo né vanità.
Ieri come oggi la coscienza del sé si annienta per fare spazio alla dominante e schiacciante dinamica dell’appartenenza al gruppo. Accettare di eseguire secondo schemi prefissi e nel rispetto di grammatiche ferree rientra nella dimensione del riconoscimento dell’identità culturale ma tutto si vive nel segno dell’obbligo di donare a se stessi e agli altri.